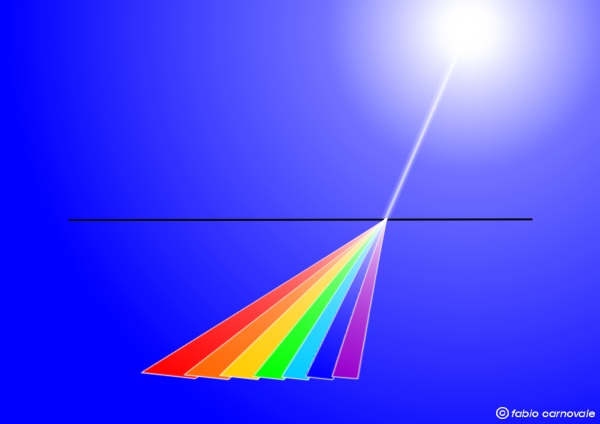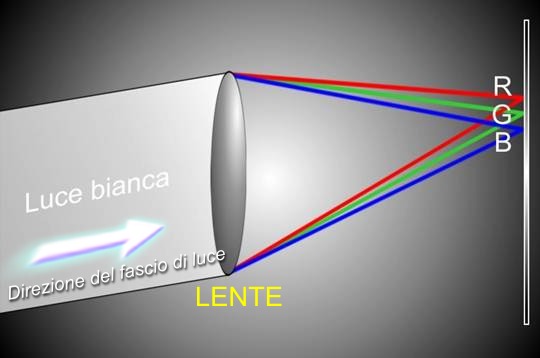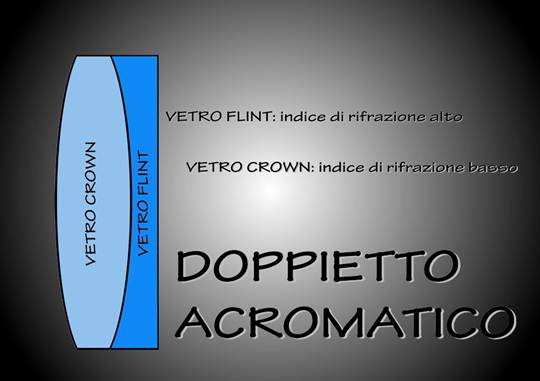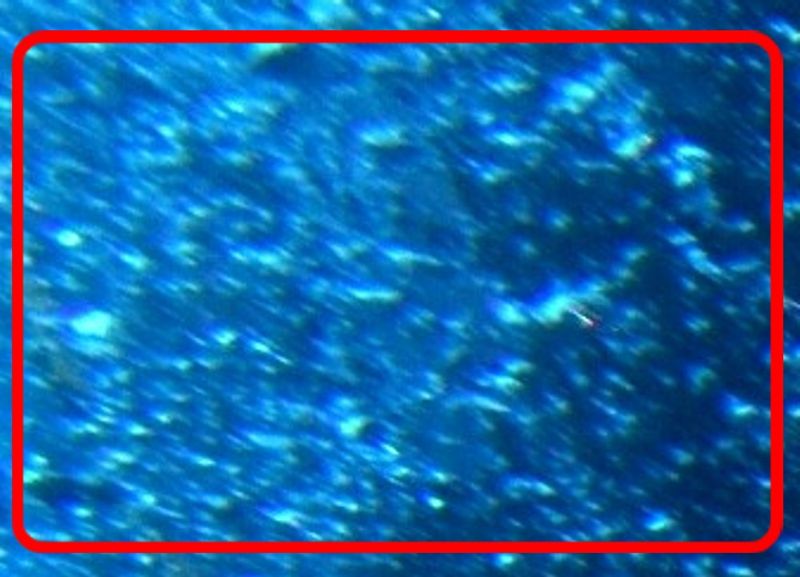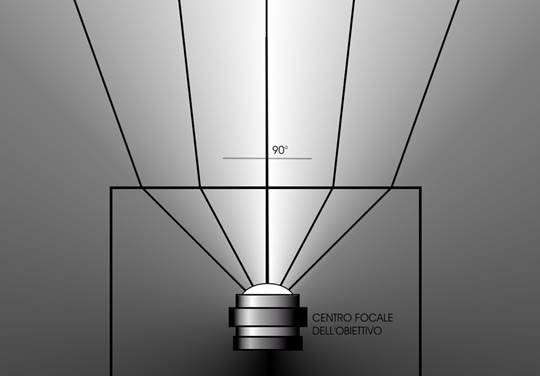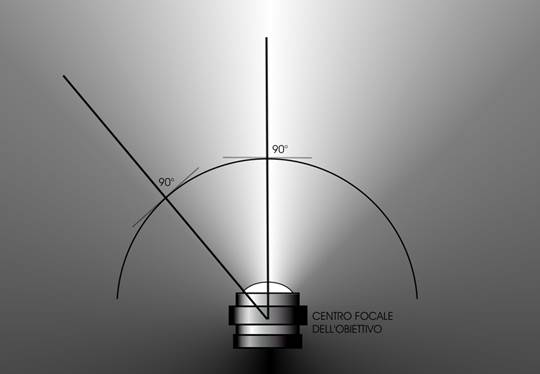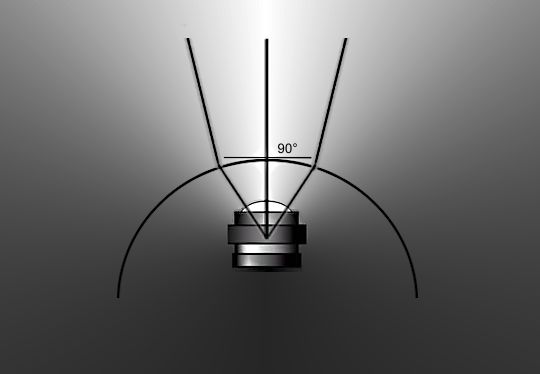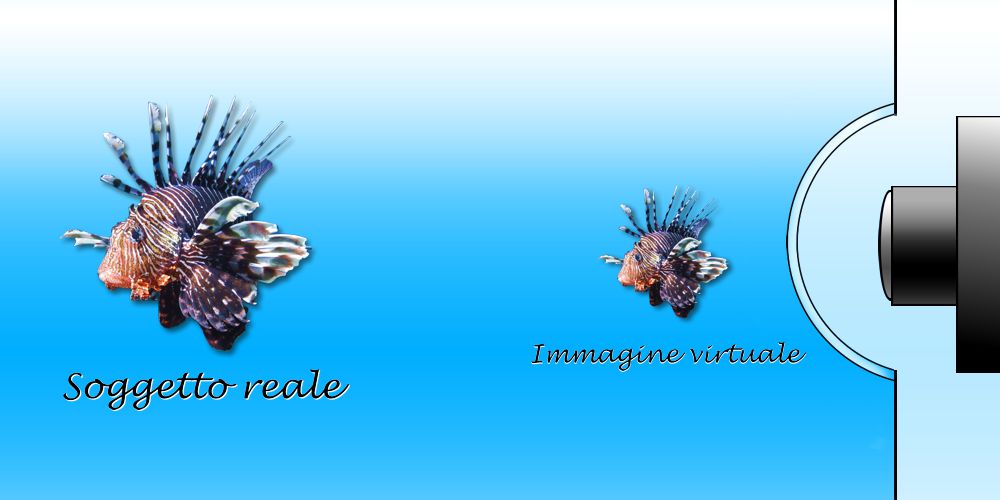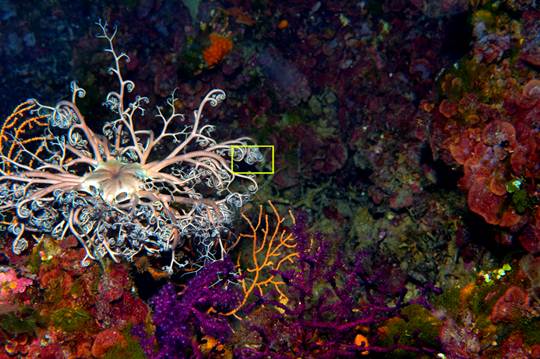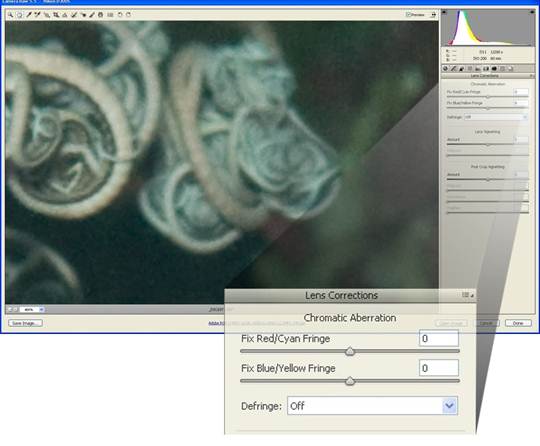|
L’aberrazione
cromatica nella fotosub
Come prevenirla (prima) e correggerla (poi)
Uno dei problemi più importanti
della Fotosub è costituito dal passaggio della luce da un mezzo
(l’acqua) enormemente più denso di un altro (l’aria).
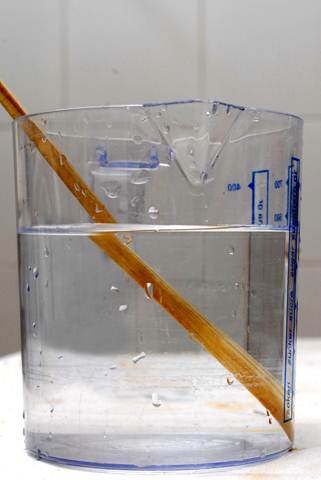 Basti
pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua
danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta
l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur
essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di
queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni. Basti
pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua
danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta
l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur
essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di
queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni.
Senza voler entrare
in dissertazioni sulla fisica delle frequenze e le lunghezze d’onda
delle onde luminose, ma esortandovi ad approfondire l’argomento,
introdurrò qui il concetto di rifrazione della luce. Quando un raggio
luminoso attraversa due mezzi con densità differente varia la velocità
con cui si propaga, pur rimanendo costante la sua frequenza. Questo, in
breve, dà luogo al notissimo effetto per cui vediamo il remo della
barca apparentemente spezzato al livello di dove entra nell’acqua.
In pratica, la
variazione di densità dei mezzi lavora proprio come qualsiasi altro
sistema ottico, che si basa sulla differenza di densità per provocare
l’effetto voluto (ad esempio una lente di vetro che devia i raggi di
luce che provengono dall’aria concentrandoli su una superficie). In
pratica, tutti sappiamo che la nostra visione delle cose sott’acqua,
con la maschera, è soggetto ad un effetto di ingrandimento che è
quantificato in circa un terzo in più, che poi è proprio la differenza
dell’indice di rifrazione fra le due sostanze.
Il classico
effetto "spezzato" dovuto alla differente velocità di
propagazione delle frequenze luminose.
I fisici e
tutti coloro che sono esperti in questa materia non storcano il naso,
questa, per mancanza di spazio, non può essere una spiegazione
scientifica e rigorosa del fenomeno ma può dare uno stimolo ad
approfondire il concetto nelle sedi opportune. Detto questo, il problema
potrebbe non essere poi così grave, basterebbe conoscere la variazione
della focale del nostro obiettivo e regolarsi di conseguenza, ad esempio
il classico obiettivo da 35mm (chi, in passato, utilizzava la Nikonos
sicuramente lo conosce bene) diventa, da grandangolare a “normale”
cioè 35mm X 1,33 = 46,55mm, che è vicino ai 50mm che è appunto il
classico “normale” terrestre. Ma le cose, ahimè, non sono così
semplici: la variazione di rifrazione non è uguale per tutte le
frequenze dello spettro luminoso. I sistemi ottici anche non subacquei
“soffrono” comunque di questo problema per il semplice fatto di
essere basati sul passaggio
di luce tra mezzi a differente densità (aria e vetro). Questo fenomeno
è analogo a quello che avviene quando si scompone il raggio di luce
bianca nei suoi componenti come avviene nel classico prisma oppure
nell’arcobaleno e fenomeni similari. Di questo se ne erano accorti già
nel ‘700 gli astronomi che, utilizzando lenti semplici per le loro
osservazioni, potevano apprezzare degli aloni colorati ai bordi degli
oggetti visionati, specialmente se questi erano chiari su sfondo scuro,
e già in questo secolo vennero progettati degli schemi ottici, basati
sull’accoppiamento di vetri a indice di rifrazione differente, per
limitare il fenomeno.
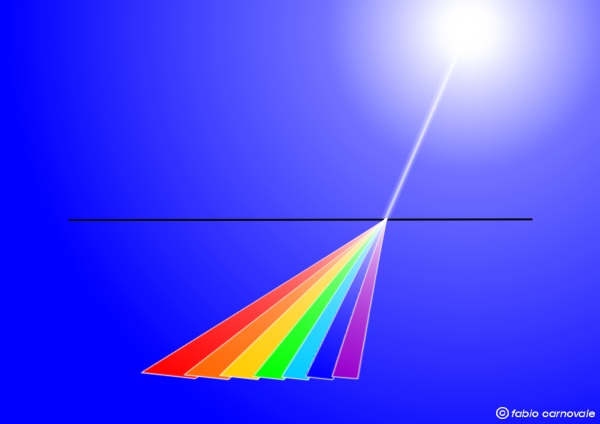
Il raggio luminoso deviato
viene scomposto nelle frequenze dello spettro visibile.


Le pagliuzze
dell’ombrellone, riprese contro uno sfondo chiaro presentano un alone
rosso da un lato e verde dall’altro.
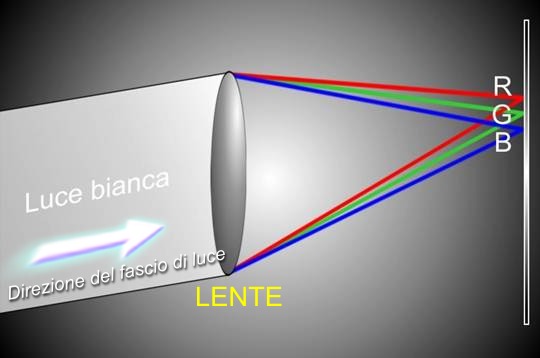
Schematizzando
il fenomeno, vediamo come le frequenza luminose siano soggette a
deviazione in modo differente.
Per ovviare a
questo problema sono stati inventati i cosiddetti doppietti acromatici:
due lenti di materiale diverso (normalmente due diversi tipi di vetro
ottico) che, unite tra loro, danno luogo ad una compensazione reciproca
del difetto.
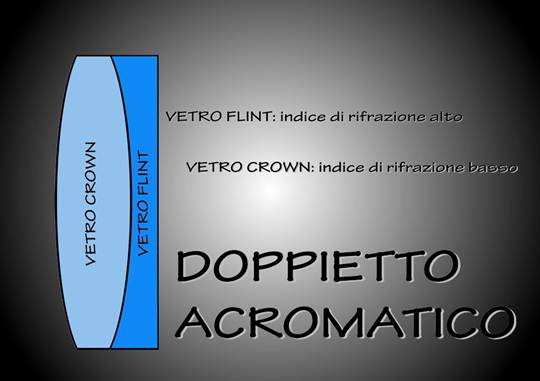
Un vetro “crown” accoppiato
ad uno “flint” si compensano a vicenda, riducendo l’aberrazione
Ma noi fotosub
in questo siamo come il classico elefante nel negozio di cristalli, il
passaggio dal mezzo acqua al mezzo aria crea un ulteriore notevole
deviazione della luce mandando a pallino tutte le sofisticate
progettazioni degli obiettivi. I difetti delle fotografie non si
limitano a microscopiche slabbrature del colore, ma a vere e
deformazioni visibili soprattutto ai lati del fotogramma, dove è
maggiore l’angolo di deviazione dei raggi luminosi.

Questa
immagine è stata ottenuta con un grandangolare (18mm) ed un oblò
piano: ingrandendo le zone periferiche agli angoli (crop 100%
dell’originale) si nota l’aberrazione cromatica, visibile come una
scomposizione dei colori ed un effetto “stiratura”
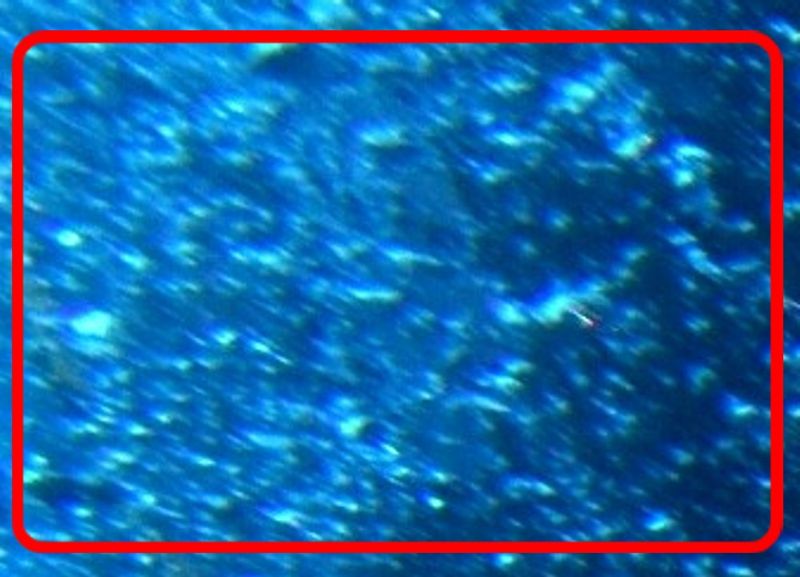
CROP dell’area superiore sinistra: le bolle
d’aria appaiono “stirate”

CROP dell’area superiore destra: si notano
le scomposizioni del colore
Vediamo ora come si
può limitare il problema in fase di ripresa e poi in fase di
post-produzione.
Per quanto
riguarda la limitazione del problema della aberrazione cromatica in fase
di ripresa, l’unica cosa da fare è dotarsi di un valido oblò
correttore. Ma in che cosa consiste? E’ quell’accessorio che fa
somigliare le nostre custodie a delle ingombranti lavatrici, la forma
sferica, precisissima, costituisce l’interfaccia acqua-aria e
impedisce la deviazione dei raggi luminosi. Il centro focale dell’oblò
sferico dovrebbe, per quanto possibile, coincidere col centro focale
dell’obiettivo, in questo modo le deviazioni dei raggi luminosi sono
molto limitate e altrettanto limitato è il fastidioso effetto
scomposizione dello spettro cromatico che vogliamo evitare. Gli oblò
possono essere costruiti in plexiglas, policarbonato od in cristallo, ve
ne sono di grandi e piccoli, a seconda delle esigenze di focale e di
ingombro. Ogni oblò, eventualmente corredato di anelli distanziatori
per adattarsi alle varie ottiche, è studiato per essere utilizzato con
determinate ottiche.
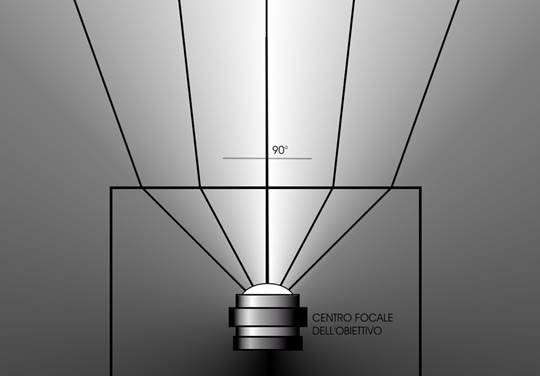
Negli oblò
piani si assiste ad una deviazione dei raggi luminosi con conseguente
aberrazione cromatica nelle zone laterale
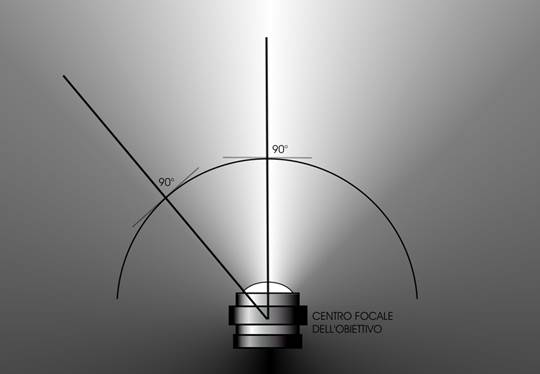
Gli oblò corretti lasciano
inalterata, per quanto possibile, la direzione dei raggi luminosi
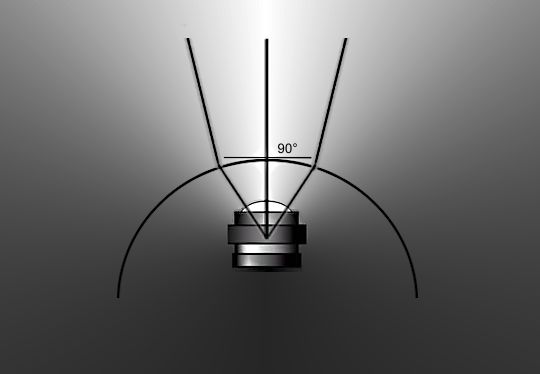
Un
oblò sferico con il centro focale dell'obiettivo
lontano dal centro della sfera e vicino alla cupola si comporta
parzialmente come uno piano.

L'oblò sferico, con adeguati
distanziatori dalla custodia, assicura una corretta geometria
dell'ottica.
L'IMMAGINE
VIRTUALE

Un fenomeno fondamentale
dell'oblò a cupola è la generazione della cosiddetta immagine
virtuale: comportandosi l'insieme acqua-aria come una lente, l'oggetto
fotografato non sarà messo a fuoco alla distanza reale ma verrà
generata una immagine falsamente più vicina e l'obiettivo dovrà quindi
focheggiare a una distanza più breve. Tanto è più piccolo il raggio
di curvatura dell'oblò, tanto più vicina è l'immagine virtuale e
l'obiettivo dovrà avere la capacità di messa a fuoco a una distanza
minima adeguata.
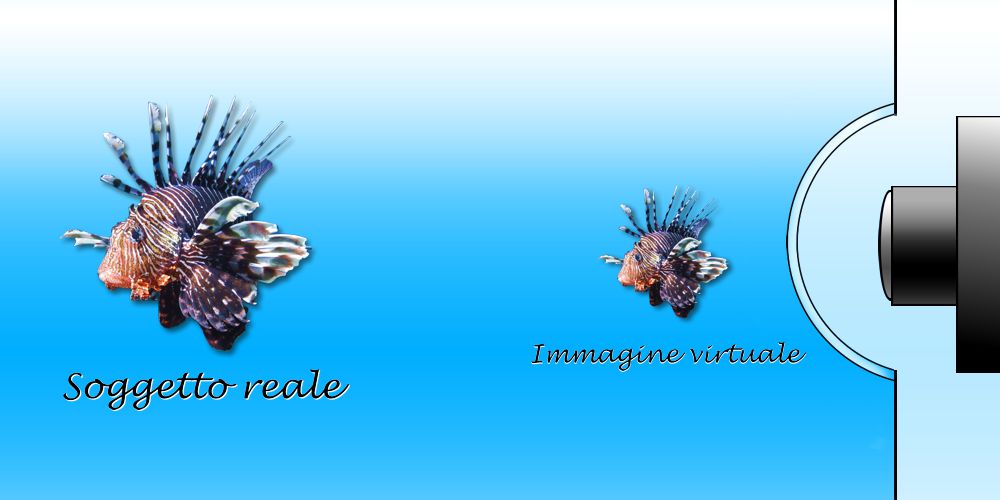
Un oblò più piccolo produrrà
una immagine virtuale più vicina (ad esempio i mini-dome, normalmente
da 4" utili per la cosiddetta "macro ambientata")

L'immagine virtuale non dovrà
cadere a una distanza minore della minima distanza di messa a fuoco
dell'obiettivo.

... in tal caso l'obiettivo non
sarà in grado di focheggiare correttamente.
Oggi abbiamo
un’altra arma efficacissima e determinante per la correzione
dell’aberrazione cromatica: l’elaborazione digitale. I metodi di
correzione sono molteplici, in questa trattazione esporrò quello più
immediato, da effettuare al momento dell’apertura del file “RAW”
in programmi come “Camera Raw” oppure “Raw Therapee” e diversi
altri. Come si può vedere, nell’anteprima del file, appare in alcune
foto effettuate con oblò piano, non corretto, il famigerato effetto
prisma: da una parte del bianco appare un alone blu, dall’altro un
alone rosso, le apposite funzioni di correzione dell’aberrazione
cromatica possono limitare se non eliminare completamente il fastidioso
effetto.
Il
meraviglioso astrospartus mediterraneum
presenta delle propaggini di colore chiaro che nella zona laterale
evidenziano il problema che trattiamo in questo articolo: l’obiettivo
è l’eccellente nikon 60 micro, l’oblò è piano e la deviazione dei
raggi luminosi si fa sentire (anzi vedere)

L’immagine intera dell’astrospartus,
la propaggine nel riquadro a destra è soggetta all’aberrazione
cromatica (60mm micro Nikkor oblò piano)

Se
ingrandiamo la zona periferica del riquadro giallo prima della
post-produzione notiamo la frangiatura del colore.
In Camera Raw
(il plug-in per aprire i files RAW in Photoshop) ma anche in altri
programmi dedicati alla medesima funzione (ad esempio Raw Therapee, che
è un freeware) possiamo correggere il difetto agendo sul comando
“correzione lente”. Nel caso in cui l’immagine non sia fruibile
dal formato “grezzo” RAW, potremo agire in modo simile utilizzando
lo stesso comando nella sezione “filtri, distorsione, correzione
lente” ma, essendo l’immagine già “sviluppata”, le possibilità
di correzione sono più limitate.

Effettuata la correzione il
difetto, pur molto evidente, sparisce.
Come dicevamo prima,
il difetto è tipico delle zone periferiche: se spostiamo
l’inquadratura della propaggine della astrospartus mediterraneum
di destra al centro del fotogramma non vi è alcuna aberrazione.
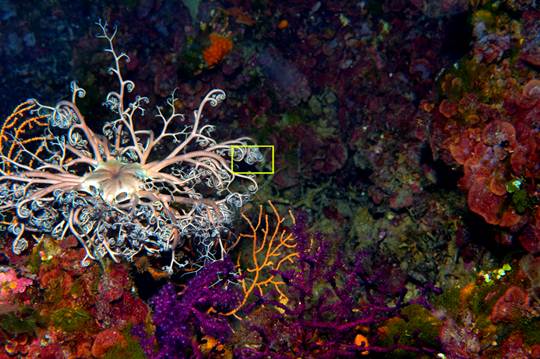
Inquadrandola
al centro la stessa propaggine dell’animale appare priva di
aberrazioni
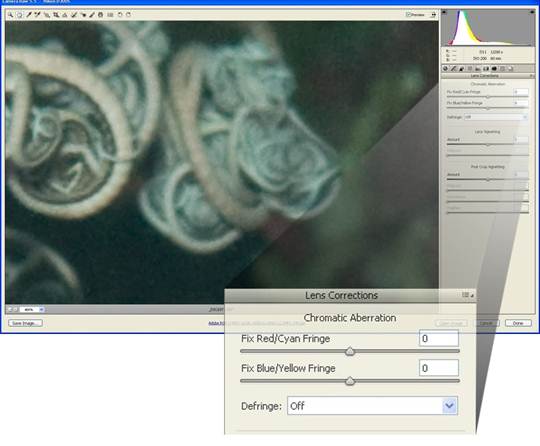
L’ingrandimento
evidenzia che con i valori di correzione dell’aberrazione cromatica su
“0” la porzione dell’immagine al centro non soffre di alcuna
sfrangiatura visibile.
In
conclusione, possiamo riassumere che oggi abbiamo grandi possibilità
per ovviare ad un problema che assilla la fotografia subacquea: la
correzione via software permette di accettare dei difetti a livello
ottico (non solo dovuti alla rifrazione ma anche a distorsioni,
vignettatura ed altro) che altrimenti ridurrebbero notevolmente la
qualità delle nostre immagini, aprendoci a soluzioni altrimenti
difficilmente percorribili.
|



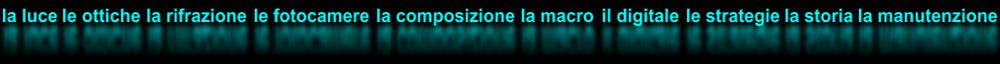


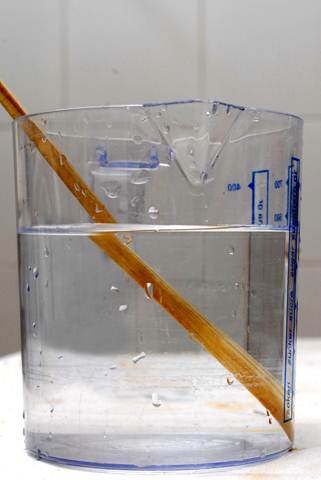 Basti
pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua
danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta
l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur
essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di
queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni.
Basti
pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua
danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta
l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur
essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di
queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni.